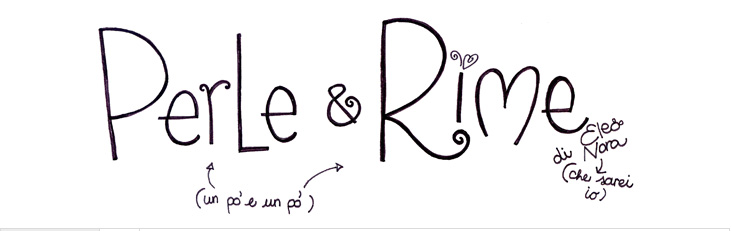Ho scritto una storia lunghissima, non so chi avrà mai voglia di leggerla. Però è una storia molto mia, e comunque è molto vera, quindi non si poteva tagliare. <3
Oggi ho voglia di raccontare una storia un po’ personale. Come quei temi banalotti che tutti i prof assegnano alla fine dell’anno, “fai un bilancio di questi ultimi nove mesi, di come sei cresciuto e cambiato”, una cosa così. Quest’anno lo faccio anch’io, perché diciamo la verità, a me guardarmi alle spalle poi piace, in fondo: mi piace vedere come tutto si modifica e sboccia, qualche volta si sciupa, ma va bene così.
Oggi che è quasi l’ultimo giorno di scuola, inevitabilmente ripenso al primo. Per me, insegnante neoassunta, era il primo settembre 2015, il giorno del primo collegio docenti: il momento in cui avrei conosciuto i miei colleghi, avrei iniziato a pianificare l’ennesima avventura, mi sarei vestita carina – ancora estiva ma non troppo, che un collegio docenti è una roba seria, e poi figurati “in una scuola di suore!” - avrei preso degli appunti bellissimi - di quelli che non ti fai sfuggire una parola, e poi non li rileggerai mai più, ma è un grande classico che si cominci così, coi propositi migliori del mondo.
Chi non insegna forse non sa che il primo collegio docenti, per tanti di noi, è un’esperienza emotivamente coinvolgente ed appassionante, ma molto stressante: è un rimettersi in gioco ancora una volta, è studiarsi a vicenda, indovinare lo stile della scuola, voler apparire credibile e seria, chiedersi se sarà la volta buona. Se l’anno successivo, finalmente, il precariato avrà fine: se i colleghi saranno sempre quelli, se comincerà una storia d’amore a lungo termine o solo un piccolo viaggio destinato a finire.
Quel primo settembre c’era ancora un gran sole da estate, e io andavo verso Lugo felice. Finestrini abbassati, musica a palla, pantaloni a fiori e la campagna altrettanto. Arrivata sotto la scuola mi sono trattenuta un minuto nella Lancia azzurrina. Un po’ perché non volevo entrare tanto in anticipo, ma soprattutto per scrivere un messaggio a lui, per dirgli quanto ero contenta e aspettare la sua risposta: anche lui era contento, scriveva. La nuova scuola mi aveva fatto una bella impressione sin dal primo colloquio, e la preside già mi piaceva. E poi finalmente un lavoro diverso: non una sostituzione di maternità, non una supplenza temporanea, non un part-time o un doposcuola. Finalmente una cattedra di italiano e storia solo per me, che sarei stata la titolare e non la sostituta… che se avessi lavorato bene sarei stata finalmente assunta, avrei avuto il mio posto senza scadenze. Che sogno. Perché io volevo un futuro: volevo un agosto da trascorrere senza l’ansia della disoccupazione settembrina, volevo l’occasione di chiedere un prestito in banca, volevo poter desiderare un bimbo senza paura di non saperlo accudire.
Poi ho varcato quel portone e ho conosciuto loro. Quelle risate e quelle facce da rientro da ferie, l’abbronzatura e i vestiti ancora leggeri, i sandali e le agende sottobraccio. Una famiglia coloratissima. I prof sono belli, sapete. Se sono prof perché lo hanno scelto, se non si sentono schiacciati dalla vita, lo capisci immediatamente: si mettono in cerchio e non sono affatto seriosi, dicono qualche boiata anche loro, ridono di aneddoti già detti e ridetti, come ragazzi di ritorno da un campeggio tra amici. E soprattutto, hanno una gran voglia di cominciare. “Cominciare” è un verbo bellissimo, e i prof ne hanno il privilegio ogni anno. La vita scolastica non è un’unica massa fluida di giornate sempre uguali tra loro: è un ciclo che si ripete e dà modo ogni settembre di “cominciare”. È un dono. A fine giugno puoi arrivare stremato, ma c’è sempre un’altra alba che incalza: i prof a settembre sono gemme esplosive, sono bambini la mattina di Natale, sono neonati che sentono il primo gelato. Sono bombe d’amore e bellezza, e non vedono l’ora che qualcuno le inneschi. Quando un prof legge i nomi dei suoi futuri alunni per la prima volta, se ancora è pieno di quell’entusiasmo e quella devozione, già se li immagina tutti e li adora. È traboccante di idee strepitose, è un innamorato al primo appuntamento, solo che ama e non sa ancora chi. Quando gli dicono che “quell’alunno è un disastro”, lui ha già deciso chi sarà il suo preferito: i prof hanno questa mania di stanare il bello un po’ ovunque.
La prima riunione stava andando benissimo. Una bella aula grande e luminosa, dei biscotti su un banco accanto alla parete. Il mio quaderno nuovo di pacca, l’astuccio turchese pieno di penne ed evidenziatori. I primi nomi li avevo già memorizzati: lei di matematica, un bel sorriso e due figlie; lei di geografia, mi ricordava una mia cara amica; lei di diritto, diceva di avermi già vista, chissà perché avevo la stessa impressione; lui di informatica, nuovo e contento come me, non prendeva appunti ma glieli avrei passati volentieri in cambio di quel Pocket Coffee. Mi sentivo già a casa e questa sarebbe una storia bellissima: la bellissima storia del mio primo giorno di scuola, se solo non fosse diventata terribile quando meno potevamo aspettarcelo. Il mio terribile primo giorno di scuola.
Non so se abbiate mai visto "Scherzi a parte". Praticamente uno si trova una tigre in garage, oppure finisce nel bel mezzo di una rapina, gli dicono che gli hanno rubato la macchina o che i suoi risparmi in banca sono misteriosamente spariti. Poi scopre che è uno scherzo, ecco, eppure non dev’essere tanto piacevole. Io quella mattina mi sono sentita così, soltanto che nessuno scherzava. Quando è entrata quella suora un po’ anziana, dagli occhi materni e un po’ tristi, e si è seduta in mezzo a noi presentandosi; quando ci ha detto che la scuola aveva dei problemi finanziari e sarebbe stata chiusa di lì a cinque anni, ecco, io ho pensato di avere capito male. Non esagero: a me mi si è annebbiata la vista, e se “a me mi” non si dice non me ne frega un bel niente. Vi sto dicendo che io potevo svenire. Lì, su quel banco, coi miei pantaloni a fiori e il sorriso ancora stampato in faccia, qualche residuo di pensiero entusiastico ancora impigliato tra un orecchio e l’altro. E così stupido, all’improvviso. Era il mio primo giorno di lavoro, e mi avevano appena comunicato la data di scadenza. Era la scuola che mi avrebbe fatta crescere come insegnante, che mi avrebbe accolta come una famiglia, che mi avrebbe vista diventare mamma… No, era una scuola che stava chiudendo. Era un tramonto. Non era un’alba. Era un malato allo stadio terminale.
Tipo. “Signora, lei ha vinto al Superenalotto: cento milioni di euro. Solo che gli euro non valgono più.”
Una sensazione così. Una doccia gelata del cazzo.
Sono andata via arrabbiatissima, e io non mi arrabbio, di solito. Non era giusto. Uno non dovrebbe vedere piangere i suoi colleghi al primo giorno di lavoro. Uno non dovrebbe firmare un contratto morente. Uno non dovrebbe concedersi di sperare, per una volta, non dico in un futuro già scritto, ma quantomeno in un abbozzo di fondamenta, per poi scoprire che c’è il terremoto, e non è mica un palazzo antisismico. Quelle tre classi che mi avevano assegnato non le volevo più conoscere, non ci volevo avere niente a che fare. Che agonizzassero da sole, nel loro oggi senza domani.
Quel pomeriggio - sul lettone di pallet che io e lui abbiamo costruito e dipinto, nella casa che chiamiamo “nostra” ma in realtà ce l’ha concessa sua nonna perché l’affitto costava troppo, con le persiane abbassate e tante cicale là fuori – io ero triste come un canto stonato. Come una lingua che non significa niente.
Oggi è il 4 giugno 2016: è quasi l’ultimo giorno di scuola. L’Istituto Tecnico Sacro Cuore di Lugo prosegue il suo conto alla rovescia. Tra pochi anni la scuola verrà chiusa: a settembre non ci sarà una nuova prima.
A pensarci è davvero un peccato, poteva essere una prima simpatica come quella attuale. Dovreste conoscerli: ventuno adolescenti chiassosi, ragazze alte e belle con i jeans molto strappati, ragazzi un po’ ancora bambini, c’è chi già fuma e chi gioca coi Pokemon, chi porta la morosa in motorino e chi stravede solo per la sua mamma, ma ho il sospetto non durerà ancora a lungo. Non si assomigliano per niente tra loro, se non per quella gran voglia di essere felici. Hanno comprato due pesci e un piccolo acquario, se ne sono presi cura per buona parte dell’anno, e nelle occasioni di festa hanno sempre dimostrato grandi doti organizzative: dei buffet così ricchi non si vedono neanche alle sagre paesane della Romagna più festaiola, nemmeno al matrimonio più ghiotto. Con loro ho intrapreso la via dell’epica e degli eroi: ho notato un certo amore per i personaggi gagliardi, temerari ed eccessivi, allora ho proposto di guardare Troy insieme. È stata una delle esperienze più divertenti dell’anno: non credevo si potesse vedere un film con il trasporto dei tifosi allo stadio, gridando nei momenti di suspence, sospirando sulle scene romantiche, applaudendo sul finale ad effetto. A volte ho proposto loro dei giochi, sempre temendo fossero troppo infantili. Si sono gasati come bottiglie di Coca Cola sulle montagne russe, e mi hanno fatta ridere fino a avere il mal di pancia.
In seconda siamo stati più poetici. Provate a chiedere a un adolescente di scrivervi una poesia: non è mica una richiesta da poco. La mia seconda si è lasciata sfidare e ha fatto a gara, lezione dopo lezione, a chi creava le strofe più struggenti o più ironiche: alla domanda “chi legge?” sempre venti mani alzate ed impazienti, non un’ombra di imbarazzo o di vergogna. Mi hanno chiesto di portarli a Recanati, e alla fine mi hanno dato ragione: Leopardi non era mica sfigato come racconta qualcuno, e poco importa se arrivati sulla spiaggia, per una pausa ludica prima del ritorno in pullman, il temporale ci ha sorpresi a scattarci selfie in costume.
La terza, invece, non mi ha mai chiesto di fare una gita culturale, ma spesso mi ha chiesto di andare a fare colazione. Un paio di volte gliel’ho concesso: quindici sedicenni più un’insegnante bionda - in molti casi più bassa e tozza di loro, spesso vestita peggio e meno truccata – che varcavano il portone della scuola per andare all’assalto del bar più gettonato di Lugo, a guadagnarsi una colazione “cornetto e cappuccino” da veri vip. La terza… la mia classe più difficile. Quella che mi ha fatta crescere. Una classe che non si lasciava incantare, che difficilmente sembrava entusiasmarsi. Che sbuffava davanti alle proposte che credevo più belle, poi però si accendeva quando meno me lo aspettavo. Un gomitolo di storie diversissime, di ferite ancora aperte: quelle di chi ha ascoltato i propri genitori litigare, di chi ha visto un proprio amico morire; quelle di chi ha molti soldi e conosce il prezzo del mondo, ma non il suo valore; quelle di chi ha fame di verità e non è disposto a lasciarsi imbrigliare, non è disposto a fare finta che essere ragazzo sia facile. La terza che mi ha comprato un regalo: una tutina con una tigre buffissima, per il mio piccolo che nasce in agosto.
Perché a un certo punto di questo anno scolastico, noi ci siamo detti che c’era un bimbo pronto per noi, probabilmente, da qualche parte nel cielo. O nel destino. E che era l’ora di accoglierlo, se voleva. Perché un contratto più o meno buono, più o meno indeterminato, non avrebbe fatto la differenza: uno non vede l’ora di amare, e allora si accorge che tutto il resto è una balla. Come era una balla che quel primo settembre 2015, con la sua afa e i suoi presagi funesti, fosse una fine e non un inizio: solo un inizio più inizio degli altri, perché chiedeva attenzioni a gran voce, perché chiedeva un po’ un atto di fede, perché non poteva dare in cambio certezze. C’è stata un’epoca in cui gli uomini cominciavano a costruire una Cattedrale, e i lavori finivano molte vite più tardi: chi iniziava non vedeva la fine, ma ci metteva tutto il cuore lo stesso. Quest’anno lo abbiamo fatto ogni mattina, e lunedì è l’ultimo giorno di scuola. Io e la mia pancia siamo i capitani della squadra blu: ci diremo “buone vacanze” giocando, senza temere la fine, felici di ricominciare ogni giorno.